Nonostante l’entrata in vigore dei nuovi LEA abbia rappresentato un passo avanti dal punto di vista normativo, l’attuazione concreta non solo resta disomogenea ma è in ritardo un po’ ovunque.
Le situazioni più critiche si registrano nel Sud Italia, ma anche al Nord non tutto è perfetto, in quanto la maggior parte dei centri fornisce unicamente prestazioni di primo livello. Ciò significa che possono essere effettuate tecniche come l’inseminazione intrauterina mentre vengono esclusi altri trattamenti come la fecondazione in vitro, che fa parte delle tecniche di secondo livello, e tecniche più avanzate come il recupero testicolare.
Analizzando le regioni, si scopre che, per esempio, il Molise non ha alcun centro pubblico né convenzionato, le Marche ne ha solo tre, di cui uno di primo, uno di secondo e uno di terzo livello, mentre l’Umbria ne ha solo uno di terzo livello.
Anche la Sardegna è poco fornita di centri: solo tre, di cui uno di secondo livello e due di terzo, così come la Calabria e la Basilicata che ne hanno uno a testa di primo livello e uno a testa di terzo. La Puglia ha quattro centri ma nessuno di terzo livello.

La situazione appare ancora più grave se si considera che le richieste di trattamenti non solo sono molto numerose ma si stima che siano anche in aumento.
I dati della SIRU segnalano che nel 2022 sono stati quasi 80.000 i percorsi di procreazione assistita intrapresi, con una percentuale di successo attorno al 20%. Ma la domanda continua a crescere, complice il progressivo aumento dell’età media alla prima gravidanza, la maggiore consapevolezza delle coppie e una più ampia diffusione delle diagnosi di infertilità.
A fronte di questo incremento, le strutture pubbliche non riescono a soddisfare il fabbisogno. In molte Regioni si registrano liste d’attesa superiori ai 12 mesi, con punte che raggiungono anche i due anni nei territori con minore disponibilità di centri. Un ritardo che, come evidenziano gli esperti, può ridurre sensibilmente le probabilità di successo, soprattutto per le donne sopra i 35 anni. In queste condizioni, non solo l’accesso è iniquo, ma anche il tempo diventa un fattore discriminante, capace di incidere sull’esito dei trattamenti tanto quanto le differenze economiche o geografiche.
Nonostante l’inserimento della PMA nei Livelli Essenziali di Assistenza sia stato pensato proprio per ridurre le disuguaglianze e rendere i trattamenti più accessibili, molte coppie italiane continuano a spostarsi da una regione all’altra, oppure a rivolgersi a strutture estere, in particolare per accedere alla fecondazione eterologa.
Secondo la Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU), la rete pubblica italiana resta ancora insufficiente, sia in termini numerici sia per quanto riguarda la distribuzione dei centri sul territorio. I centri di terzo livello sono spesso concentrati in poche Regioni, lasciando vaste aree del Paese prive di un’offerta adeguata.
Il risultato è un aumento della cosiddetta mobilità sanitaria, che costringe molte coppie a sostenere spese di viaggio e soggiorno in altre città o Paesi, con un forte impatto economico ed emotivo. Un’esigenza che tocca soprattutto chi vive nel Sud Italia o nelle aree interne, dove l’assenza di centri pubblici convenzionati o l’impossibilità di accedere alla fecondazione eterologa rende il ricorso al settore privato – nazionale o straniero – spesso l’unica alternativa concreta.
Finché non verranno colmate queste lacune e armonizzata l’applicazione dei LEA su tutto il territorio nazionale, il diritto alla genitorialità resterà un percorso a ostacoli per troppe persone.
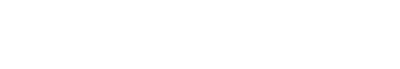

Copyright © 2019-2022 All Rights Reserved by PMA-ITALIA | Privacy Policy – Cookie Policy – Impostazioni Cookies
Links

